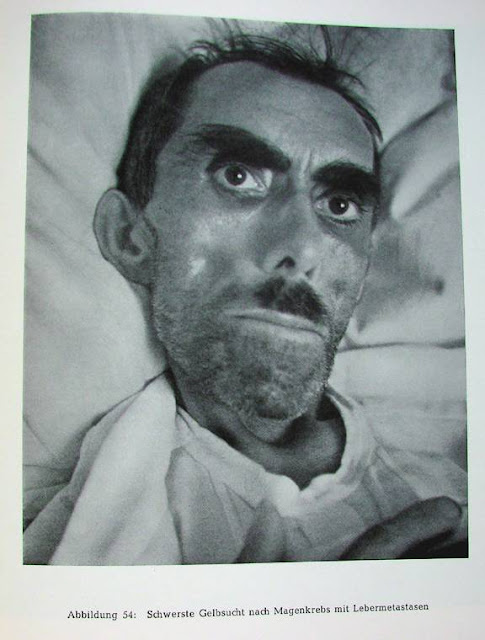Vi ricordate il volto ironico e sofferente di Massimo Troisi che pedala, a
picco sul mare, nel film Il postino?
Gli straordinari autoritratti, molti dei quali inediti per l’Italia, di Dick
Ket sembrano riportarlo alla mente. E ci fanno entrare, in punta di piedi, in
una vita silenziosa, vissuta in pochi metri quadri. Una storia leggera e trasparente come una pelle di cipolla, che mi piace
condividere, prima che voli via.
Dick Ket è stato un pittore e incisore olandese della prima metà del
Novecento noto per le sue nature morte e per gli autoritratti con le “dita a
bacchetta”, conseguenza della sua patologia. Ha prodotto in tutto centoquaranta
dipinti, la maggior parte dei quali negli ultimi dieci anni di vita.
Di questi, quaranta sono autoritratti. E questo, qualcosa vorrà dire.

Cult per chi lo conosce, soprattutto in Olanda, sconosciuto ai più, Dirk Hendrick
Ket nasce nel 1902 a Den Helder, piccolo porto all’estremo nord dei Paesi
Bassi, con un difetto cardiaco grave, probabilmente la tetralogia di Fallot
(detta anche sindrome del bambino blu), all’epoca incurabile, che gli provoca
un insufficiente nutrimento di tessuti e organi. E le dita a mazza di tamburo
o, come dicono i medici, dita ippocratiche.
È gracile, un lungagnone dagli occhi grandi e lucidi, e diviene subito
vittima di bullismo in classe, anche perché, al seguito del padre militare, è
costretto a cambiare frequentemente scuola e città e deve ogni volta lottare
per farsi accettare.
Mentre frequenta il secondo ciclo di studi incontra però due
insegnanti che ne comprendono il talento e lo incoraggiano.
Johan C.
Kerkemeijer, suo insegnante di disegno, gli consiglia di valorizzare il suo
talento artistico e lo indirizza verso le tecniche della pittura a olio. Un
altro suo professore, Henri Adrien Naber, insegnante di chimica e fisica,
teosofo convinto e autore di lavori scientifici nei quali vorrebbe dimostrare
il rapporto tra geometria e misticismo, lo influenza profondamente nella
visione della vita e delle cose.
Le teorie
di Naber lo conducono così a ricercare un parallelismo tra leggi della fisica
ed esistenza. A dare un senso al suo essere malato. Ma anche a pastrocchiare
con gli elementi. E come risultato delle sue azzardate sperimentazioni tecniche, alcune sue
tele, dopo mezzo secolo, non sono ancora completamente asciutte. Dopo gli studi d’arte alla Kunstoefening, l’accademia di Arnhem, tra il 1922 e il 1925, Dick non riesce più a viaggiare. Debilitato dalla stanchezza cronica indotta dalla sua malattia e da crescenti fobie, soprattutto l’agorafobia, finisce così per vivere appartato, con i genitori, a Bennekom, una piccola cittadina proprio al centro dei Paesi Bassi, lontana dal mare davanti al quale è nato. Se cercate su Street View il numero 70 di Prins Bernhardlaan, a Bennekom, vedrete una piccola fortezza di due piani, costruita con un ammirevole stile funzionalista che ancora oggi stride con le casette tradizionali che la circondano. È la dimora che Dick Ket si è progettato e dalla quale, dopo il 1930, non uscirà più.
Sarà l’evoluzione del suo volto, nei suoi
autoritratti, a raccontare da questo momento, con spiazzante crudezza, l’avanzamento
progressivo della malattia. Cianosi compresa. Morirà pochi giorni prima di compiere trentotto anni. Perplesso e malinconico, mai
disperato, anche quando si ritrae in un trittico di memorie rinascimentali con
una pezza in testa, occhi gonfi e in mano una ciotola che ha tutta l’aria di
essere maleodorante.
Capace di esprimere nelle lettere – pubblicate postume – umorismo e
autoironia, passione per le arti, per la letteratura, la musica, il cinema, ma
anche per i giochi di parole e l’enigmistica. Perché i geni, a volte, sanno
sorridere, anche nella tragedia.
Ecco il
trucco. Non era necessario per lui dipingere un mare. Se vuoi esplorare il tema
dell’acqua, è sufficiente spiarne la caduta da un rubinetto in una ciotola, il
resto è solo scenografia.
Stessa
cosa per l’umanità. Basta cercare il mondo in te stesso e nelle persone che
fanno parte del tuo pianeta. Come Nel Schilt, la sua ragazza, che spesso
ritrae, e suo padre, che considera il suo migliore amico.
Mentre i primi dipinti esplorano suggestioni postimpressioniste, dal 1929
appare fortemente influenzato dalla Neue Sachlichkeit e quindi dal Magischer Realismus, termine coniato
dal critico d’arte Franz Roh in un celebre saggio del 1925, dove lumeggia una “terza realtà”, sintesi fra mondo concreto e la
dimensione magica dei sogni e delle allucinazioni, movimento che Dick arriverà
a conoscere solo attraverso riproduzioni, ma che sente come suo.
Nonostante
l’isolamento, riesce comunque a esporre. Tra il 1932 e il 1940 sue opere
figurano in mostre collettive di pittura olandese contemporanea, tra Amsterdam,
Eindhoven e L’Aja, ma anche a Bruxelles, Venezia e Parigi. Si è assicurato una
certa notorietà grazie a una mostra personale – la prima e l’ultima, purtroppo
– tenutasi tra il 1933 e il 1934 alla Kunstzaal Van Lier ad Amsterdam, dove la
sua pittura è stata apprezzata, non senza qualche polemica, e diverse opere
sono state vendute.
Le sue meticolose nature morte presentano pochi elementi. Bottiglie, una
ciotola vuota, uova, strumenti musicali, un grappolo d’uva, ritagli di
giornale. Ket propone questi oggetti comuni con tagli angolari, visti ora
dall’alto, ora in scorcio. Piegando la tecnica analitica alla volontà di
comunicare emozioni.
Spesso sono presenti anche citazioni tratte da illustrazioni o dalle
pubblicità del cioccolato Droste disegnate da Cassandre, al secolo Adolphe Jean
Marie Mouron, celebre illustratore e pittore francese di origini ucraine, che
figurano come elemento contemporaneo in uno scenario classico, all’antica. Ma è
nell’interpretazione di se stesso che Dick apre una pagina tra le più toccanti
della pittura. Come nell’Autoritratto del
1932. In una composizione che si diverte a evocare i classici della
ritrattistica del Rinascimento tedesco e italiano, vediamo il suo aspetto
bizzarro e sofferente, contraddistinto dalla strana pigmentazione della pelle e
dalla forma delle dita “a bacchetta”, sintomatiche della malattia, che si
colorano sempre più di grigio-blu. Ha la camicia aperta sul torace, a evocare
il suo problema cardiaco. E stringe con forza il fiore nella brocca, per dire
che la vita non gli sfuggirà senza lottare.


Ha un cavalluccio alle spalle, forse per alludere all’innocenza infantile
del proprio sguardo sul mondo, e lo inserisce anche in altre sue composizioni.
D’altronde, nella bassa parlata fiamminga, ket
significa proprio “cavalluccio”, “ragazzino”. Nell’angolo in basso, a destra,
ha dipinto capovolta la parola “FIN”, quasi a ricordare la morte che incombe.
In una miscela di ironia e tragedia che lo rende, non solo come pittore, una
grande figura del Novecento.
È morto il 15 settembre 1940, nel periodo più buio della guerra.
Mi sarebbe piaciuto averlo come amico.
The Three Bread Rolls, 1933
LA FAMIGLIA. GLI AMORI.
SOLO LUI POTEVA ANDARE SULLA COVER DI OUTSIDERS.
-->
storia di 34 sconosciuti,
dimenticati, inappropriati artisti del ‘900. Un omaggio ai perdenti e alla
creatività dispersa. Una esigenza nata anche per valorizzare il mio lavoro di
creativo, mettendo accanto fotografi e pittori, illustratori e scultori. Storie
da tutto il mondo, che volevo raccontare prima che svanissero. Qualcuno è stato
piegato da difficoltà, guerre, malattie, perseguitati perché ebrei, folli,
omosessuali. Qualcuno ha inseguito l’amore, altri hanno combattuto battaglie
perse in partenza. Perché gli Outsiders sono perdenti per definizione. Non
scelgono mai i luoghi e le date giuste per nascere,
creare, amare, morire. Vivono in mondi paralleli. E hanno sempre l’indirizzo
sbagliato.
Giunti Editore.